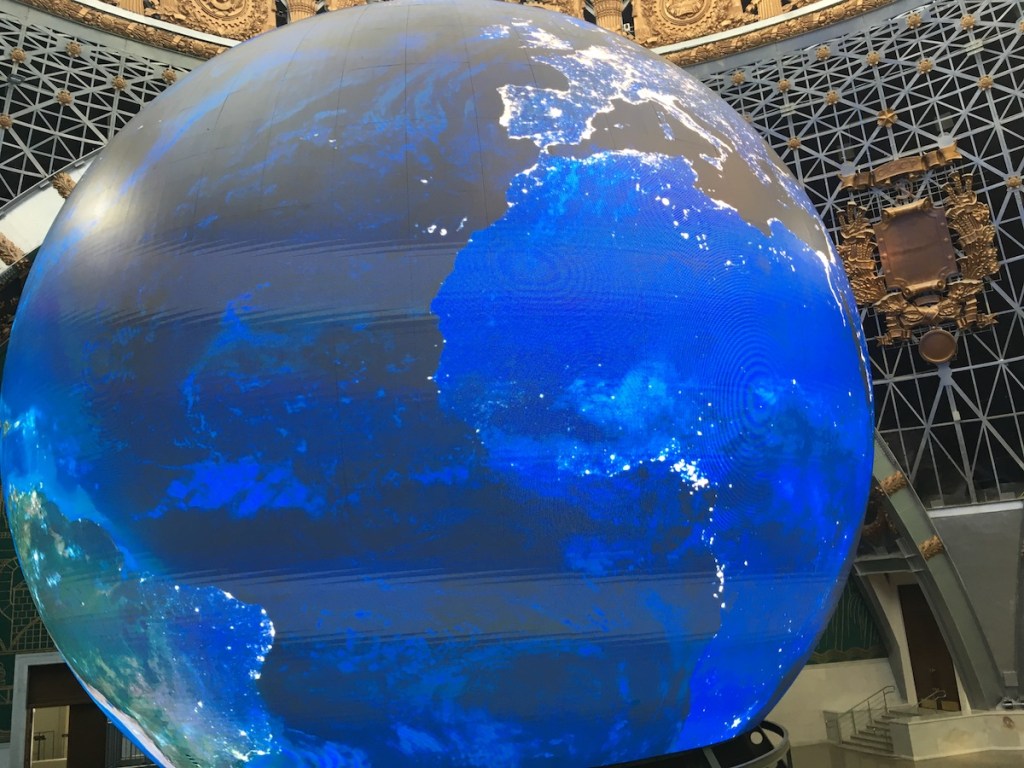[7 maggio 2020, Facebook]
Miei cari,
da quando siete partiti il mondo è cambiato. Riuscite a immaginare da dove vi scrivo? A quale mezzo affido il mio messaggio per voi? Non adopero una delle vostre Olivetti. Nelle vostre vite pestavate sui tasti. Col ricorso a tappeti di feltro pensavate di attutire i colpi sulle macchine calde, e di non disturbarmi. Ma esattamente così non andava. Vi sentivo.
Le Olivetti non si usano più, né i primordiali personal computer che avete fatto in tempo a vedere (e sgranavate gli occhi). Insomma da dove vi scrivo? Da una bacheca sociale. E digitale. È un luogo promiscuo nel quale altri possono leggere il mio messaggio per voi, che diventa lettera aperta agli affetti. Questi “altri”, dei quali io stesso faccio parte, sono nomi e personalità senza corpo, parole pure che si raccolgono nello spazio virtuale dove ora voi mi leggete. Questo è il mio luogo, seppure anche io debba usare una tastiera e l’alfabeto che già conoscete, e vi scriva dalla casa che molto tempo fa avete lasciato, da qui, proprio da qui, non sorprendetevi, dove resto sigillato ormai da due mesi, perché è scoppiata un’epidemia e mi è proibito di uscire.
Immagino il vostro stupore. Un’epidemia. Una pandemia. È arrivata morte collettiva nella mia vita. Pericolo di tutti. Fervore e solitudine. Potete comprendermi? Tu puoi comprendermi, che nascesti nel ‘15 e combattesti tre guerre? Anche tu puoi comprendermi, venuta al mondo nel ‘39, quando veniva al mondo l’ultima guerra?
Vi prego, nessuna preoccupazione per me, niente soprappensieri. Siccome vado scomparendo, io sto bene. Questo volevo farvi sapere in lettera aperta. Mi allontano e sto bene. Appassisco e sto bene. Non potreste immaginare il ragazzo che non sono più. Ricorderete forse il ragazzo chino sui libri di storia, e appassionato. Prima di partire, il vostro preoccupato pronostico fu per una vita di studio. Si avverò per un poco. La tua partenza era calda, quando andai a Milano per il dottorato, la tua partenza mi distraeva nella grande aula, chiamato a esporre progetti per la commissione professorale, e invece pensavo alla gonna e al cappotto nei quali eri partita, alle calze di nylon per sempre. Pensa che ora non si può andare a Milano, né in treno, né in macchina o aereo, e nemmeno a piedi.
Pensa che ora la mia vita non ha corrisposto al vostro pronostico. Ho scelto una vita diversa. Ho cercato il più a lungo possibile di non prendere ordini. Odio gli ordini. Odio i comandi. Dalla tua partenza, avevo 26 anni, bado a me stesso. Ho fatto la spesa, ho risolto questioni pratiche. Sono fiero di aver badato a me stesso. Ma ho iniziato troppo presto, e in quel modo, senza ultime istanze, senza gradi di appello, dovendo badare a me stesso o morire, mi sono trasformato in un maturo bambino, improvvisamente adulto, fragile durevolmente.
Ma questo volevo dirvi: non importa e me la sono cavata. Scomparendo sento di rilassarmi, come se bevessi whisky in faccia alla storia. Svuoto il mio calice e non sopravvaluto il dovere di vivere. In stato di ebbrezza, sottovalutare si può. Peccato solo che non abbiate letto i miei libri. Qualche racconto, un paio di romanzi. Mi avrebbe fatto piacere mostrarveli. Ma se voi non foste partiti così presto, io non avrei scritto quei libri e non avrei potuto mostrarveli. Insomma che complicazione le cause e gli effetti.
Mi accorgo che voi siete per me la preistoria, e che io sono per voi fantascienza. Tranquilli: eccettuate epidemia e tecnologia, conservo fattezze umane, mi copro con vestiti pesanti nell’inverno più rapido e adopero le stoffe leggere di sempre nelle lunghe stagioni del caldo.
Mi sognate? Io vi ho sognati. È ovvio che ci siamo sognati. Tengo per me il racconto onirico vostro, preferisco non spogliarmi, restare negli abiti davanti a voi. Venite a trovarmi nei sogni, io vi raggiungo nei vostri. Il racconto è superfluo.
Per la festa del partigiano ho messo alla serranda una bandiera tricolore. Perdonami: tu mettevi bandiere rosse. Ma ho aggiunto un fazzoletto rosso, ricordo molecolare di te. Poi, ogni sera, cucino in casa con la mia compagna, un’estranea per voi mi dispiace. I ristoranti sono ancora chiusi. Teatri e cinema anche. Ma noi abbiamo due ore di serenità, mentre si prepara e apparecchia la tavola, e poi quando si cena. Beviamo vino e parliamo.
Ecco, questo volevo farvi sapere, laggiù dove siete finiti: che beviamo vino e parliamo ogni sera, che beviamo vino e ridiamo. Quindi va tutto bene, per un poco ancora.
Spero che anche voi condividiate la mia serenità. Ricordatevi di me come io vi ricordo, e ogni tanto mandate notizie.
Con affetto, d.
Dedicato a Frederika Randall